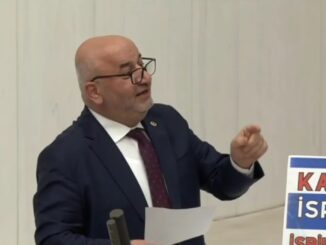L’Arabia Saudita si presenta oggi al mondo avvolta in un manto di modernizzazione e apertura, come se un nuovo corso l’avesse davvero trasformata. Ma basta sfiorare quella patina scintillante per intravedere, intatto, il volto di un potere autoritario che reprime il dissenso, soffoca le libertà fondamentali e converte il consenso internazionale in moneta di scambio, con petrolio e promesse di investimenti.
La visita di Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti è più di un viaggio diplomatico. È l’ennesima dimostrazione di come la retorica della democrazia si svuoti, quando a guidare l’agenda sono armi, contratti e ambizioni personali. L’indiscrezione su un jet di lusso da 400 milioni di dollari offerto dal Qatar, indipendentemente dalla sua natura, è emblematica: non solo per il sospetto di conflitti d’interesse, ma per ciò che simboleggia. L’attrazione irresistibile del denaro del Golfo su una leadership americana sempre più disinvolta nell’intrecciare interessi pubblici e vantaggi privati.
Il nome di Jamal Khashoggi, ucciso brutalmente nel consolato saudita a Istanbul, non dovrebbe essere rimosso così in fretta dalla memoria delle diplomazie occidentali. E invece, a quasi sette anni da quell’assassinio, Mohammed bin Salman è saldamente al potere, protetto da un’architettura propagandistica ben collaudata: eventi sportivi, riforme superficiali, investimenti tecnologici. Tutto utile a ridisegnare l’immagine del Regno, nulla che incida realmente sulla sua natura repressiva.
I primi cento giorni della seconda presidenza Trump rivelano una continuità inquietante. Le politiche verso Gaza e lo Yemen sono prolungamenti brutali delle scelte precedenti. Né sorprende più che le differenze tra Biden e Trump in Medio Oriente si assottiglino fino a svanire. La questione dei diritti umani è sistematicamente subordinata a interessi geopolitici e convenienze commerciali. Si firmano accordi, si stringono mani, si fotografano sorrisi. Intanto, le carceri restano piene, le voci dissidenti vengono silenziate, e la libertà rimane un lusso riservato a pochi.
Una democrazia degna di questo nome non può restare indifferente al destino di chi è perseguitato per aver chiesto giustizia o verità. La “realpolitik” non può diventare alibi per l’inerzia morale. Non può giustificare il mutismo sulla repressione nei Paesi del Golfo, né l’indifferenza per il dramma palestinese, o per la violenza che ancora oggi devasta lo Yemen.
Il vero scandalo non sta soltanto negli accordi stipulati. Sta nell’accettazione passiva di un ordine in cui i diritti civili sono trattati come variabili accessorie, sacrificabili sull’altare della stabilità e del profitto. Eppure, il silenzio, specie quando è comodo, è sempre una scelta. Così come è una scelta quella di chi rischia la libertà o la vita per difendere un principio.
Non si chiede l’isolamento del Medio Oriente. Si chiede coerenza. Si chiede che le relazioni internazionali non ignorino deliberatamente chi viene incarcerato per un post, chi viene torturato per un’opinione, chi viene ucciso per raccontare ciò che accade.
La storia non si scrive con le transazioni, né con le corti reali. Si scrive con il coraggio di chi non tace. E oggi, come sempre, è da quel coraggio che deve ripartire ogni discorso credibile sui diritti civili. Anche nei luoghi dove il deserto non è solo paesaggio, ma metafora del vuoto morale lasciato dall’Occidente.