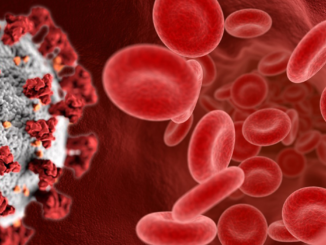Il Rapporto Bes 2024 dell’Istat consegna un’Italia che fatica a tenere il passo dell’Europa. Non è una novità, ma la freddezza dei numeri di quest’anno rende più difficile ricorrere ai soliti alibi. Su 39 indicatori confrontabili con la media Ue27, il nostro Paese è in svantaggio su 18. E se un terzo degli indicatori generali migliora, la quota di quelli stabili o peggiorati rimane maggioritaria. È l’immagine di un Paese che avanza troppo lentamente, mentre i partner europei procedono, spesso, con un altro passo.
Il primo nodo è il benessere economico, il rischio di povertà in Italia tocca il 18,9%, ben sopra il 16,2% europeo. Non si tratta di una fluttuazione momentanea, l’incidenza della povertà assoluta cresce quasi ininterrottamente dal 2014, fermandosi soltanto nel 2019 grazie al Reddito di cittadinanza e a una momentanea ripresa dei consumi delle famiglie più fragili. Oggi, invece, l’inflazione ha eroso i redditi reali e il 9,8% degli italiani vive in povertà assoluta. Un Paese che si proclama avanzato non può considerare fisiologico che un cittadino su dieci non riesca a permettersi l’essenziale.
Il mercato del lavoro non offre rassicurazioni. Il tasso di occupazione si ferma al 67,1%, quasi nove punti sotto la media europea; tra le donne la distanza diventa un baratro: 57,4% contro il 70,8% Ue. La forbice del part-time involontario, poi, è la misura di un sistema produttivo che non offre lavoro dignitoso ma frammentazione, l’8,5% degli occupati italiani è intrappolato nel part-time non scelto, contro il 3,2% europeo; tra le donne il divario è ancora più eloquente (13,7% vs 4,8%). Non è solo un problema sociale, è un freno strutturale alla crescita.
Sul fronte dell’istruzione, l’Italia continua a occupare le ultime posizioni nell’Unione. Solo il 31,6% dei giovani tra 25 e 34 anni ha una laurea, contro il 44,1% della media europea; appena il 66,7% degli adulti ha almeno un diploma, mentre nell’Ue la quota supera l’80%. È un arretramento che non nasce oggi ma che oggi presenta il conto, investiamo troppo poco in capitale umano e troppo tardi pretendiamo di competere nell’economia della conoscenza. Non sorprende, dunque, che la spesa in ricerca e sviluppo sia ferma all’1,37% del Pil, lontana dal 2,22% europeo, e che nelle professioni scientifico-tecnologiche manchi personale qualificato.
C’è poi un indicatore spesso ignorato nel dibattito pubblico ma cruciale per comprendere qualità della vita e sostenibilità del welfare: la speranza di vita in buona salute. Qui l’Italia perde terreno. Pur restando tra i Paesi più longevi d’Europa, gli anni di vita vissuti in salute scendono a 58,1, un calo rispetto al 2023 e ai livelli pre-pandemici. Allarmante il dato femminile: 56,6 anni, il valore più basso dell’ultimo decennio. Viviamo più a lungo, ma non necessariamente meglio.
Infine, il tema della sicurezza, spesso brandito come arma politica, mostra un peggioramento di diversi indicatori nell’ultimo anno. Nonostante i progressi nel lungo periodo, la tendenza recente dovrebbe invitare a più pragmatismo e meno propaganda.
Il quadro del Bes non è un atto d’accusa ideologico, è un termometro. E il termometro dice che l’Italia soffre una combinazione pericolosa di fragilità economica, arretratezza formativa, squilibri sociali e peggioramento delle condizioni di salute percepita. Uscire da questo circuito richiede più investimenti e meno slogan, più politiche basate su evidenze e meno autoassoluzioni.
L’Italia non sta crollando, ma sta scivolando. E continuare a ignorare il ritmo di chi ci supera significa accettare che il declino diventi la nostra nuova normalità.