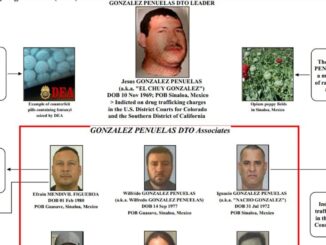C’è il mondo, con le sue guerre, le sanzioni, le diffidenze reciproche. E poi c’è il cosmo. Una dimensione parallela che sembra vivere di regole proprie, dove persino Russia e Stati Uniti, divise da fratture geopolitiche, continuano a collaborare come se nulla fosse. L’International Space Station (ISS), sospesa a quattrocento chilometri sopra le tensioni terrestri, resta il simbolo più tangibile di questa resilienza.
Nell’aprile 2023 la NASA, insieme ai partner europei, giapponesi e canadesi, ha ribadito la volontà di mantenere operativa la stazione almeno fino al 2030. Mosca, dal canto suo, ha garantito l’impegno fino al 2028. Una linea temporale più corta, ma sufficiente a mostrare che, nonostante i venti di guerra, la cooperazione nello spazio non è ancora crollata. Il resto del mondo costruisce muri, ma lassù si continua a lavorare fianco a fianco.
Il segnale più sorprendente è arrivato nell’estate del 2025. Il 31 luglio Dmitrij Bakanov, capo di Roscosmos – l’agenzia spaziale governativa della Federazione Russa – si è recato negli Stati Uniti per incontrare Sean Duffy, amministratore pro tempore della NASA. È stata la prima visita di questo livello dal 2018. In quell’occasione, secondo quanto riferito da The Moscow Times, Bakanov ha dichiarato: “Abbiamo concordato che opereremo la ISS fino al 2028… e lavoreremo sulla questione della sua deorbitazione entro il 2030”. Un’affermazione che ha fatto il giro delle agenzie e che l’Associated Press ha rilanciato con ulteriori dettagli, riportando come i due abbiano discusso non solo della stazione orbitale, ma anche di “ulteriori lavori sulla Stazione Spaziale Internazionale, cooperazione sui programmi lunari, esplorazione congiunta dello spazio profondo e continua collaborazione su altri progetti spaziali”. La cooperazione, insomma, non si è fermata nemmeno davanti alla guerra con l’Ucraina e alle sanzioni. Bakanov lo ha detto chiaramente: “Farò tutto il possibile per mantenere aperto il canale di cooperazione tra Russia e Stati Uniti, e mi aspetto che la NASA faccia lo stesso”. Parole pesanti, pronunciate in un momento in cui Mosca è sempre più isolata sul piano internazionale. Eppure, in orbita, la Russia resta un partner imprescindibile.
Non che manchino le difficoltà. Il segmento russo della ISS soffre da tempo di problemi tecnici: perdite d’aria, usura strutturale, segnali che la stazione sta invecchiando. Nel giugno 2025 un’anomalia di pressione nel modulo Zvezda ha persino costretto la NASA a rinviare una missione privata. Ma la collaborazione non si è interrotta: “L’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale prosegue regolarmente le proprie attività in condizioni di sicurezza”, ha confermato l’agenzia americana a The Washington Post. È il paradosso del cosmo: anche quando la politica spinge alla rottura, la necessità di garantire la sicurezza degli equipaggi obbliga a tenere aperti i canali.
Certo, le dichiarazioni russe hanno bisogno di un sigillo politico. Lo stesso Bakanov ha ammesso che, “considerata la complessa situazione geopolitica, sarà necessario il via libera dei leader dei nostri Paesi”. È un’ammissione che non annulla la cooperazione tecnica in corso, ma ne sottolinea la fragilità: nello spazio prevale la logica della scienza e della sicurezza, sulla Terra quella della diplomazia e della guerra.
Osservando i lanci che continuano dal cosmodromo di Baikonur, la sensazione è quella di un avamposto neutrale, sospeso sopra le fratture della politica. Il 28 febbraio 2025 la navetta cargo Progress MS-30 ha lasciato la steppa kazaka alle 00:24 ora di Mosca, diretta verso la ISS . L’8 aprile è stato il turno della Sojuz MS-27, che alle 05:47 UTC ha portato un nuovo equipaggio in orbita, ancora una volta fianco a fianco russi e americani. Il 3 luglio un’altra nave di rifornimento, Progress MS-31, è partita alle 19:32 UTC dal sito 31/6 di Baikonur, seguita l’11 settembre dal lancio di Progress MS-32, avvenuto alle 17:54 UTC. E a fine anno, il 27 novembre, è atteso il decollo della Sojuz MS-28, previsto per le 07:26 UTC: la data è stata resa pubblica da Roscosmos e compare su fonti come Spacefacts.de, e portali di tracciamento lanci come NextSpaceflight e RocketLaunch.
È in questi ritmi, in queste partenze regolari che si rinnova l’immagine della Stazione Spaziale Internazionale come “isola neutrale”: un avamposto di pace che resiste alle intemperie della politica internazionale. In orbita non si parla di sanzioni, ma di moduli da riparare, esperimenti da condurre, vite da proteggere.
La vita della ISS, però, non sarà eterna. Nel 2024 la NASA ha affidato a SpaceX la costruzione del veicolo che guiderà la stazione verso una fine controllata, “far rientrare la stazione spaziale nell’atmosfera e garantire l’assenza di rischi per le aree popolate”, dopo il 2030. È l’atto che segna il passaggio al dopo.
E il dopo, per gli Stati Uniti, è un mosaico di stazioni commerciali. Axiom punta a diventare una piattaforma autonoma già nel 2028, dopo aver cambiato la sequenza di montaggio dei suoi moduli per anticipare l’indipendenza. Starlab, frutto della joint venture Voyager–Airbus, ha completato la Preliminary Design Review nel marzo 2025 e si prepara alla fase successiva entro fine anno. Orbital Reef, di Blue Origin e Sierra Space, avanza più lentamente ma ha già testato scenari di vita a bordo con simulatori a grandezza reale. A inizio settembre, l’amministratore pro tempore della NASA, Sean Duffy, ha ribadito che “per venticinque anni la NASA ha guidato la presenza umana in orbita bassa terrestre… ora chiamiamo a raccolta i nostri partner commerciali perché raccolgano il testimone e custodiscano questa eredità storica”. Segno che la transizione è imminente e che non ci sarà spazio per vuoti operativi.
La Cina gioca su un altro tavolo, con una stazione già in orbita, Tiangong, che presto sarà ampliata da un modulo multifunzionale e dal telescopio spaziale Xuntian, previsto per il 2026. Non più un progetto, ma un presente consolidato che si espande.
La Russia, infine, prepara la propria via autonoma con la ROSS (Rossijskaja orbital’naja služebnaja stancija, la stazione orbitale russa). I piani prevedono il lancio del primo modulo scientifico-energetico nel 2027 e un nucleo a quattro moduli entro il 2030. Una scelta che nasce tanto da esigenze tecniche – l’invecchiamento del segmento russo della ISS – quanto da motivazioni strategiche: spostare il baricentro su un’orbita più alta, utile all’osservazione del territorio nazionale e al controllo militare.
E così, in questo settembre 2025, lo sguardo da lassù restituisce un’altra prospettiva: un presente di cooperazione che resiste, pur tra fratture sempre più profonde, e un futuro fatto di partenze divergenti. L’ISS rimane ancora sospesa, fragile ma tenace, ponte reale tra due mondi che a terra si respingono. Non prima del 2030 verrà accompagnata verso la fine — forse persino nel 2031, secondo alcune proiezioni — ma fino ad allora continuerà a imporsi la logica della necessità: tenere viva la stazione, proteggere gli equipaggi, guadagnare tempo per preparare la prossima era dell’esplorazione.
Il cosmo, per ora, resta un territorio franco: un luogo dove la scienza e la sopravvivenza prevalgono sulla politica, e dove la cooperazione resiste come un tenue filo di pace che ancora lega l’umanità sopra le sue divisioni.
Riproduzione riservata.