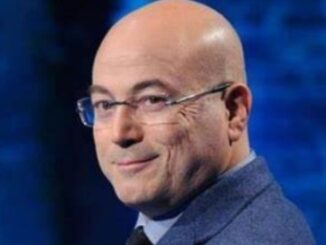Lo scandalo di corruzione esploso nel cuore del sistema energetico ucraino arriva nel momento peggiore possibile per Kyiv. Mentre i missili russi continuano a colpire infrastrutture critiche e l’inverno minaccia di trasformarsi nel più duro dall’inizio della guerra, il governo Zelensky è costretto a gestire una crisi interna che rischia di erodere la fiducia dei cittadini e, soprattutto, quella degli alleati occidentali.
Energoatom, tangenti e ministri in fuga: un danno d’immagine devastante
I fatti sono ormai noti, un sistema di tangenti del 10-15 per cento su tutti i contratti di Energoatom, quasi 100 milioni di euro sottratti allo Stato, ministri costretti alle dimissioni, e imprenditori vicini al presidente in fuga all’estero. Il quadro è talmente sgradevole da risultare ingestibile persino per un governo che, dalla notte dell’invasione russa, ha fatto della trasparenza e della resistenza morale la propria bandiera internazionale.
La risposta di Zelensky: necessaria, ma non ancora sufficiente
Zelensky ha reagito in modo rapido ma non necessariamente convincente, rimpasto ai vertici dell’azienda nucleare, nuovi organismi di controllo, commissioni parlamentari, una ripulitura forzata del governo. Una serie di interventi che sommano più un’esigenza di contenimento politico che una vera svolta. Il sospetto, alimentato dalle stesse proteste popolari, è che l’indagine sia emersa non grazie all’Esecutivo, ma nonostante esso. E questo, in un Paese che chiede all’Europa e agli Stati Uniti enormi sacrifici economici, pesa come un macigno.
Le reazioni europee: preoccupazioni, pressioni e opportunismi
Ed è proprio in Europa che lo scandalo ucraino rimbalza con effetti politici significativi. La Germania, per bocca di Friedrich Merz, ha fatto sapere senza giri di parole che Kyiv deve dimostrare molto di più nella lotta alla corruzione. In altri Paesi la notizia ha offerto argomenti facili a chi da tempo mette in dubbio la necessità di finanziare la resistenza ucraina.
Il caso italiano: Salvini frena, Crosetto corregge, Tajani rilancia
Il caso italiano è emblematico. Le parole di Matteo Salvini, «non vorrei che i soldi degli italiani finissero nella corruzione ucraina», non rappresentano solo l’ennesimo esercizio di ambiguità geopolitica. Sono la manifestazione di una frattura reale all’interno della maggioranza. Una frattura che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha cercato di ricomporre con un paragone che definire azzardato è dir poco, l’aiuto angloamericano all’Italia nonostante la mafia. L’obiettivo era chiaro, ricordare che si aiuta un popolo, non i suoi corrotti. Ma il risultato è stato quello di rendere ancora più visibili le contraddizioni interne all’esecutivo.
Ancora più dissonante è la posizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che annuncia senza tentennamenti un nuovo pacchetto di aiuti militari mentre il suo alleato di governo frena e polemizza. Una diplomazia sbilanciata, che rischia di presentare all’estero un’Italia affaticata, esitante e poco affidabile nel momento in cui gli alleati cercano certezze, non sfumature.
Il paradosso politico: fragilità che si alimentano a vicenda
Il paradosso è che entrambe le discussioni, la corruzione a Kyiv e le divisioni italiane, finiscono per intrecciarsi in una spirale pericolosa. La fragilità interna ucraina offre agli scettici europei un pretesto perfetto; il caos politico europeo riduce la pressione su Kyiv per riformare davvero il proprio sistema. E la Russia osserva, e sfrutta.
La solidarietà non è un assegno in bianco
La guerra ha imposto alle democrazie un equilibrio delicatissimo tra sostegno militare e vigilanza politica. Ma nessuno dei due pilastri può essere sacrificato. Kyiv ha l’obbligo morale e politico di dimostrare che la sua lotta non è solo contro la Russia, ma anche contro le proprie zone d’ombra. Roma, e l’Europa, hanno il dovere di reagire con lucidità, senza farsi intrappolare né dal cinismo né dall’ingenuità.
La solidarietà non è un assegno in bianco. È un patto. E un patto, per reggere, richiede fiducia.